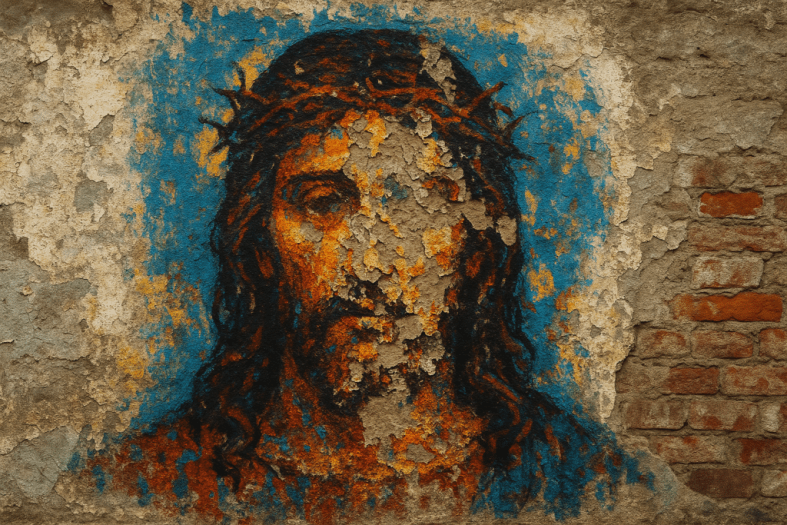Aggiungo anch’io qualche parola al dibattito tra Roberto Repole e Vito Mancuso, sul quale in molti hanno scritto – non ultimo Stefano Fenaroli qui su Vinonuovo.it – provando a riflettere sulle questioni e tralasciando i giudizi sulle persone.
Mi pare che l’oggetto della discussione, su impulso di Mancuso, si sia spostato dal tema centrale dell’articolo di Repole, ossia il futuro della fede cristiana e della Chiesa a fronte della crisi attuale, a quello dell’esclusività della Salvezza attraverso Gesù Cristo. Questo spostamento nasce, a mio parere, da un fraintendimento da parte di Mancuso (e di Fenaroli): nel suo testo Repole non affronta il tema dell’esclusività della Salvazza cristiana. La frase incriminata – “Io sono cristiano perché credo fermissimamente ciò che dice Pietro nel libro degli Atti: che non c’è nessun altro nome in cui c’è salvezza, se non Gesù Cristo” – è una citazione (evidentemente fraintendibile) posta a conclusione di un testo la cui tesi fondamentale è che l’adesione a Gesù Cristo permette, ancora oggi, di accedere alla vicinanza di Dio, alla bellezza di una vita buona e umanizzante, e che da qui la Chiesa deve ripartire. Come sottolineato da Maurizio Gronchi nella sua replica a Mancuso, Repole, citando At 4, non può aver voluto dire qualcosa di diverso da quanto il Concilio Vaticano II ha affermato in merito alla Salvezza, aprendola a “tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia” (Gaudium et Spes 22). Nessuna affermazione di esclusività dunque. Non è questo quindi, a mio parere, il tema sul quale vale la pena soffermarsi.
La questione vera posta da Repole è la crisi che incontrano la Chiesa e la fede cristiana oggi e come affrontarla, ed è su questo che vorrei spendere qualche parola provando ad approfondire e facendo qualche rilievo alla prospettiva del Vescovo di Torino. Nella sua disamina ciò che Repole individua come causa della situazione attuale è il venir meno di un’adesione convinta e testimoniale a Gesù Cristo da parte dei cristiani: “oggi non mi preoccupa che la Chiesa diventi minoranza, ma che non si percepisca che il Dna della Chiesa è Gesù Cristo”; “io credo che molti cristiani non sentano più l’urgenza o la bellezza di annunciare e testimoniare Gesù Cristo agli altri”. La sua proposta è quindi suscitare un nuovo radicamento in Gesù Cristo per costruire comunità cristiane che, pur se minoritarie, siano presenze significative nella società, per l’umanità. Il passaggio che Repole però non chiarisce – e che a mio parare è decisivo – è il motivo di questo venir meno oggi, anche tra i cristiani, del riferimento a Gesù Cristo. Da cosa è causato? Nel testo afferma di credere che “molti cristiani facciano proprio il nichilismo contemporaneo”, ma perché di fronte al nichilismo la proposta cristiana risulta essere così poco attraente, così poco convincente e competitiva? Perché in un mondo in cui “c’è poca fiducia nella vita e nel futuro, […] una cultura che non offre spiragli di speranza” la fede e la speranza cristiana non riescono ad essere delle risposte credibili? Un tempo senza speranza non dovrebbe essere un terreno fertile per chi si professa portatore di speranza, come i cristiani?
Da questo punto di vista sono d’accordo con quanto afferma Mancuso: “il problema, sia chiaro, non è del mondo, che va per la sua strada, ma del cristianesimo, le cui chiese rimangono vuote”. Il problema non è un mondo in cui “una cosa vale l’altra” ma una proposta cristiana che non riesce a farsi percepire come qualcosa che vale davvero. E qui, secondo me, è decisivo il tema della Salvezza cristiana, di cui tanto si è discusso rispetto all’esclusività, ma della quale né Repole, né Mancuso danno una definizione precisa. La Salvezza è ciò che la fede cristiana offre come possibilità al credente, ciò che Gesù Cristo, morto e risorto, e la fede in lui rendono possibile per i suoi discepoli. In cosa consiste questa Salvezza? Tenendo come riferimento GS 22 potremmo sintetizzare dicendo che Gesù Cristo salva l’uomo dal peccato, dalla morte e, potremmo dire, dalla “separazione con Dio”. Ora, è del tutto evidente come nel contesto attuale l’offerta di Salvezza dal peccato (con tutte le controversie che porta con sé rispetto al tema della grazia, del peccato originale, del sacrificio espiatorio…) e dalla morte risultano essere risposte a domande che non ci sono. Perché – sintetizzando male temi che chiederebbero molto più approfondimento – l’uomo di oggi percepisce come un’ingiustizia l’idea che si nasca già segnati dal peccato; vive il senso di colpa, il pentimento, la richiesta di perdono nel contesto delle relazioni interpersonali, non nel rapporto con Dio; focalizza la sua attenzione e la sua preoccupazione sulla vita concreta di ogni giorno, non su ciò che accadrà dopo la morte; non trova alcun valore in un’esistenza vissuta nel sacrificio o nell’aderire a prescrizioni morali in vista di una vita futura; percepisce come infantile e poco credibile la descrizione dell’aldilà propria dell’immaginario cristiano (giudizio, inferno, purgatorio, paradiso) preferendovi piuttosto, anche tra i credenti, descrizioni derivate da altri contesti culturali. Questo, prima di essere qualcosa con cui si è più o meno d’accordo, rappresenta un dato di fatto di cui prendere atto. Se la Salvezza cristiana è questo, se ciò che la relazione con Gesù Cristo offre è questo – che è quello che afferma la dottrina cristiana, che si insegna a catechismo, che si ripete nelle formule delle nostre liturgie deserte – è chiaro che il cristianesimo non ha nulla da offrire al mondo di oggi. (Con questo non sto affermando che questi temi debbano essere rimossi o che non siano veri per un credente, ma che qui l’uomo di oggi non trova nulla di interessante e desiderabile per la propria vita).
Questo è il motivo per cui oggi, anche tra i cristiani, viene meno l’adesione a Gesù Cristo, perché ciò che lui offre è associato nella maggioranza dei casi a qualcosa di cui nel contesto odierno non si sente alcuna esigenza. Di questo sembra essere consapevole anche Repole, che non a caso (ma sorprendentemente, a ben vedere) nel suo intervento, quando parla di ciò che Gesù Cristo rende possibile, non fa riferimento alla Salvezza dal peccato o dalla morte, ma alla “consapevolezza che Dio si è fatto vicino”, a un’“etica e a una vita buona che nascono dall’adesione a Gesù Cristo”, al “patrimonio del Vangelo” che motiva l’impegno sociale, la preferenza per i poveri, la lotta contro le ingiustizie… Una prospettiva incentrata sull’oggi, su ciò che di buono e di bello l’uomo Gesù, che la fede cristiana chiama Dio, ci consegna come possibilità di vita. Da questo punto di vista Repole va nella stessa direzione di Mancuso, ossia quella della tanto discussa spiritualità (dove la differenza tra i due permane nel riferimento esplicito ed esclusivo a Gesù Cristo in Repole, che Mancuso integra con altre tradizioni, le quali però, nella sostanza, si muovono nella stessa prospettiva). Coincide questo con il terzo “aspetto” della Salvezza, che ho sinteticamente chiamato “Salvezza dalla separazione con Dio”. GS 22 recita così: “Il cristiano poi, reso conforme all’immagine del Figlio che è il primogenito tra molti fratelli riceve «le primizie dello Spirito» (Rm8,23) per cui diventa capace di adempiere la legge nuova dell’amore. In virtù di questo Spirito, che è il «pegno della eredità» (Ef 1,14), tutto l’uomo viene interiormente rinnovato”. In questa prospettiva la Salvezza cristiana consiste nell’essere abitati dallo Spirito di Dio – in questo senso non più separati da Dio –, nell’incontrare e fare proprio l’amore di Dio; quello stesso amore incarnato da Gesù Cristo, così da assumere nella propria vita il suo stesso sguardo, il suo stesso desiderio, i suoi stessi sentimenti. Significa riscoprire nei gesti, negli incontri, nelle parole di Gesù, nella sua tenerezza, nel suo rifiuto dell’ingiustizia, nel suo amare fino alla fine, l’evidenza di una bellezza capace di dare senso alla vita, capace di diventare bussola per gli sguardi e le scelte di ogni giorno.
Questa prospettiva spirituale (della quale ad esempio la teologia di Paolo Gamberini prova a rendere ragione nella prospettiva del post-teismo) è ben lontana dal considerare Dio e lo spirituale “come una realtà amorfa, indistinta, che tutto comprende, […] qualcosa che dovrebbe separarci da questo mondo, da questa realtà, cercando il proprio senso, la propria felicità in un “cielo” spirituale, dove non ci sono più differenze…” come scrive Fenaroli. Dà valore invece a quanto nelle Scritture e nella tradizione cristiana si afferma rispetto all’opera dello Spirito nell’uomo, alla presenza di Dio nel mondo e del mondo in Dio. Non per proporre di vivere al di là del mondo, ma radicati nel mondo, operando guidati dallo Spirito di Dio; non per annullare le differenze ma per affermare ciascuna come manifestazione inevitabilmente finita e parziale dello Spirito. Per rendere accessibile oggi ciò che la tradizione cristiana porta con sé da sempre, ma che è troppo spesso rimasto sepolto dietro una teologia e dei linguaggi che non dicono più nulla.
È a questo livello che la vicenda di Gesù può avere, secondo me – ma anche secondo Repole e Mancuso – ancora qualcosa da offrire all’uomo di oggi, perché viviamo in un mondo in cui “una cosa vale l’altra”, ma dove, soprattutto tra i più giovani, la ricerca di qualcosa che abbia senso è presente e viva, ed è con rassegnazione che vi si rinuncia. Il modo nuovo di essere Chiesa, di aderire e testimoniare Gesù Cristo, di cui parla Repole, non può che passare da qui, avendo il coraggio di ricentrare su questo livello l’annuncio cristiano.
Una precisazione prima di chiudere: è evidente come a questa spiritualità sia possibile giungere a partire da Gesù Cristo (Repole) così come da altre prospettive (Mancuso), coerentemente con quanto affermato da GS 22 riguardo la Salvezza accessibile a “tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia”.